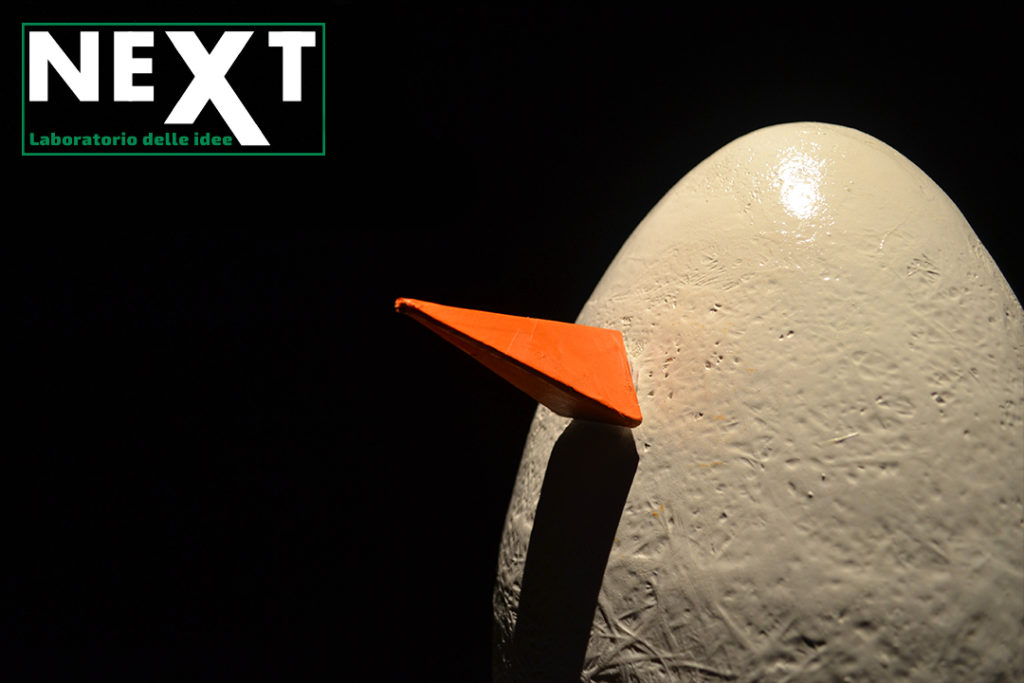Cari cuccioli di Compagnia Rodisio
Cari cuccioli è uno spettacolo tenero, pieno di poesia e delicatezza, un haiku che contiene immagini emozionanti, create con una perfezione scenica dove ogni elemento è pesato nei minimi dettagli. Manuela Capece e Davide Doro – fondatori della compagnia Rodisio, ideatori e interpreti del lavoro qui presentato – appaiono come figure smussate e indefinite dalla fitta nebbia che accoglie il pubblico appena entra nella sala teatrale. Rivolto ai bambini dai 2 ai 5 anni, accompagnati dalle loro famiglie, lo spettacolo non utilizza parole, ma si affida alla potenza di immagini visionarie che, intrecciate a una colonna sonora dai toni fortemente lirici, affascinano piccoli e adulti conducendoli al di là del bosco, in un territorio impalpabile e soffice, un posto segreto dove vi sono cura e dolcezza. I due attori attraverso gesti coreografici e pochi oggetti che piano piano appaiono dal nulla e si collocano nello spazio – una finestra, una poltrona, un materasso, un fuoco acceso, un albero fiorito, la luna piena – ricreano una casa essenziale, un ambiente pronto ad accogliere ciò che verrà, il futuro che cresce. Cari cuccioli lavora su più livelli interpretativi e intreccia elementi ripresi dalle fiabe classiche e archetipi ancestrali: si attraversa il bosco e si bussa alla porta perché il nuovo è ciò che non si conosce e che proviene da fuori. Se lo spettacolo per i bambini può rappresentare un’iniziazione all’esperienza teatrale, per i genitori è il racconto della condizione che si attraversa quando ci si prepara a diventare genitori. La casa è pronta, il latte è nella tazza, il fuoco è acceso e si aspetta che la nuova vita, il caro cucciolo, bussi a quella porta. Il rito è iniziato. (c.t.)
Alan e il mare di Giuliano Scarpinato
Ci sono spettacoli che dividono il pubblico in maniera netta. O almeno l’impressione, all’uscita, è che vi siano punti di vista contrapposti. Raramente capita, come nel caso di Alan e il mare, ultimo lavoro di Giuliano Scarpinato, che la spaccatura sia così marcata che si trovino spettatori in lacrime, perché commossi e altri paonazzi, perché arrabbiati. Alan e il mare è – almeno questa la sensazione al debutto a Segnali di Milano, con un pubblico però solo di adulti e di addetti ai lavori – uno di quegli spettacoli che non lascia indifferenti e che pone subito alcune domande cruciali, anche metodologiche, che sono poi le domande che riguardano il settore del teatro ragazzi, ma che in realtà comprendono tutto il teatro. Dopo il polverone di Mi chiamo Alex e sono un dinosauro, spettacolo sull’identità sessuale, Scarpinato, sempre per un pubblico a partire dai 7-8 anni, sceglie un argomento altrettanto scottante, come i viaggi tragici dei tanti stranieri che scappano dalle guerre. Una provocazione o il desiderio di spingere il teatro ragazzi dentro le grandi questioni dell’attualità? Una mossa à la page o “necessaria”?

La prima domanda riguarda dunque la tematica: è opportuno raccontare a bambini di sette-otto anni le tragedie degli immigrati che muoiono in mezzo al mare? Un po’ frettolosamente, a rischio di ideologia, si può rispondere di sì, basta trovare la forma giusta (d’altronde Art Spiegelman ha raccontato l’olocausto con i fumetti, riuscendoci, Benigni con il cinema, meno convincente…). E dunque: qual è la forma giusta? Come si racconta una tragedia? Lo spettacolo parla di un padre (Federico Brugnone) che si imbarca con il proprio figlio a Bodrum per fuggire dai bombardamenti. Una terribile tempesta colpisce lo scafo e il bambino muore affogato. La storia si sviluppa dal punto di vista del padre che, in preda a deliri o sogni o visioni, mantiene un filo, un dialogo, un rapporto con il figlio, trasformatosi in una sorta di pesce. Il padre tenta invano di trascinarlo fuori dall’acqua, fino a che, in un processo doloroso di accettazione del lutto, si immerge nelle profondità marine, alla scoperta di un nuovo mondo. Ci sono sentimenti di angoscia, di paura, ma anche molta dolcezza e immaginazione. La tragedia viene infatti strutturata con le dinamiche della fiaba. Il figlio – interpretato dal bravo Michele Degirolamo – sguscia sul palcoscenico come un pesce fuor d’acqua, e il pensiero va subito a Colapesce, antichissima storia siciliana e di tutto il meridione, di cui esistono decine di varianti (oggi disponibili per Donzelli con le bellissime immagini di Fabian Negrin, probabilmente il più bravo e costante illustratore di fiabe dei nostri anni). E allora la domanda potrebbe diventare: è opportuno trasformare una realtà tragica in una fiaba (dai risvolti tristi in questo caso, ma che contiene in sé, quasi per statuto, una sorta di “cura”, di catarsi, di rielaborazione?). Le “fiabe sono vere”, diceva Italo Calvino, ammonendoci, in un certo senso, rispetto alle derive più evasive e inconsistenti. Le fiabe cioè andrebbero prese sul serio, perché rispondono ad elementi profondi dell’animo umano. Ma che tipo di processo educativo si può innescare nella dinamica che trasforma la realtà in fiaba? Quali i pericoli? Come si evita la rappresentazione ammiccante e finzionale, inevitabilmente fallace? La “cura” di cui è portatrice la fiaba, anche quando parla di morte, di cosa è fatta? Come evitare la retorica sentimentale?
Scarpinato ha talento e coraggio, ma sceglie di camminare su una strada scivolosa e per mantenere il giusto equilibrio è obbligato ora a togliere, ora ad aggiungere elementi; è costretto a pigiare su uno stato emotivo, per ottenere un primo piano efficace, ma qualcosa sullo sfondo va inevitabilmente a perdersi. La guerra e l’iniziale disperazione sono appena accennate e lo spettacolo si concentra sul rapporto padre e figlio (la madre, con il velo, è solo un’immagine virtuale, muta, che sembra vivere ormai in un altro mondo, una vera alterità nella sua assenza…). La scenografia è composta da pannelli, organizzati come fossero le schegge di uno specchio rotto, sui quali sono proiettate immagini che riscaldano il clima emotivo, spesso contraddistinto da forti elementi di pathos e di commozione, e da momenti ludici. Ad esempio il viaggio verso il mare si segue sullo schermo in soggettiva, come un videogioco, con bonus da guadagnare e nemici da sconfiggere. Qualcuno si lamenta, sostenendo che trasfigurare questi viaggi disperati con il filtro del game è una falsificazione o una mancanza di rispetto. È però vero che, di fronte al pubblico dei più piccoli, il video gioco è una porta di ingresso fortissima, una sintesi visiva molto efficace, che trasmette, metaforicamente, l’idea di pericolo e di viaggio. Che il viaggio dei migranti oggi sia l’unico riconducibile in qualche modo alle narrazioni picaresche è un fatto evidente e che, anche nella disperazione assoluta, possa entrare l’avventura, come genere letterario, lo ha dimostrato Primo Levi con il suo romanzo forse più bello, La tregua. Il genere dell’avventura non è il videogame, ma che nell’immaginario collettivo vi sia stato questo slittamento è assodato e con questa immagine è giusto forse fare i conti. Ma è questo – l’avventura – che si vuole trasmettere? Solo in piccola parte, perché lo spettacolo è ricco di tante altre invenzioni ed è costruito con abilità nella mescolanza di registri e di tecniche, con una sensibilità tutta contemporanea, concentrandosi soprattutto sul rapporto padre-figlio. Forse è addirittura troppo pieno di elementi, che rischiano di confondere qualche passaggio e forse, a tratti, è teso a sedurre e a sorprendere. Ad esempio i tentativi di riportare “in vita” il figlio, l’idea di una sopravvivenza oltre la morte (nel ricordo), sono allo stesso tempo visioni di un uomo impazzito per troppo dolore, sogni, miraggi, cortocircuiti temporali tra passato, presente e futuro… La parabola fiabesca impone in qualche modo una conclusione, una chiusura, per cui si corre nell’elaborazione del lutto. In questo caso storia e fiaba stridono tra loro: da una parte il lutto che ferma tutto, blocca la storia, fa precipitare lo stato emotivo, dall’altra la fiaba che deve trovare una conclusione, far ripartire la vita e che perciò rischia di apparire una scorciatoia.
La cifra un po’ barocca dello spettacolo può infastidire, perché per una vicenda del genere ci si aspetterebbe più sobrietà, così come apparentemente avviene per altri lavori presenti al festival Segnali. In realtà lo stile è la forza dello spettacolo. I due attori, in dialogo con la scena, riescono a dar vita a un linguaggio vivace e convincente. La forma è sofisticata ed è padroneggiata con sicurezza. Certe invenzioni visive e gestuali non possono che avvicinare la “storia” al pubblico dei più piccoli. L’intenzione è chiara. E anche le nuove tecnologie, oltre che per gusto, vengono utilizzate come “ponti”: si sta parlando dell’oggi, non dell’Odissea, e questi stranieri usano gli stessi nostri oggetti.
Più che insistere sulla disperazione della guerra o su differenze culturali tutto lo spettacolo punta sulle similitudini. E il dolore di un padre per la morte del proprio figlio è cosa universale, propria della natura umana. È come se tutta la storia volesse concentrarsi su questo aspetto e quindi paradossalmente subisse un processo di “normalizzazione”. L’impressione finale è che la forza di questo lavoro (che ha senz’altro forza) coincida con il suo stesso limite, cioè l’ambizione. L’ambizione di camminare sul filo di tante cose: dei sentimenti dei padri e dei figli, della cronaca e della fiaba, della politica e dell’indignazione, dei nuovi media e del nostro immaginario. È una bella ambizione, che in parte trova risposta concreta e in parte lascia qualche dubbio, che vale la pena tenere sospeso. Tra le altre cose pare un po’ insistito il riferimento al “caso” mediatico suscitato dalla foto, che ha fatto il giro del mondo, di Aylan Kurdi, il piccolo profugo senza vita sulla spiaggia, da cui lo spettacolo prende spunto. Un riferimento che forse porta fuori strada. Piuttosto rimane grande la curiosità delle reazioni che potrebbe avere un bambino. I bambini sono immersi dentro questa trasformazione epocale ancor più degli adulti. Nelle scuole dei più piccoli storie di stranieri giunti in Italia in modo rocambolesco sono all’ordine del giorno. Ecco che di fronte a un richiedente asilo che si incontra per strada un bambino può chiedere cento cose: chi è? Da dove viene? Come ha fatto ad arrivare fin qui? In un certo senso con questo spettacolo è come se si dicesse che dietro a un’immagine mediatica, dietro a un volto si può nascondere un grande lutto, un grande dolore, una storia terribile di ingiustizia, un essere umano come noi, ma a tutte le altre domande dovranno rispondere genitori, insegnanti, educatori. (r.s.)
Mister Green di Elsinor-Vat Teater
Qual è il rapporto dell’uomo contemporaneo con la natura? È ancora possibile trovare un contatto con l’ambiente prendendo le distanze dalle sovrastrutture che la contemporaneità ci impone? Siamo disposti a ritrovare un dialogo “ecologico” con la realtà, rinunciando alle comode mediazioni della modernità? Queste domande sembrano essere al centro del progetto Mister Green, seconda presenza internazionale a Segnali, frutto di una coproduzione di Elsinor con la compagnia estone Vat Teater. Si tratta di un lavoro dal forte impatto visivo, con una scenografia fatta di videoproiezioni che accompagnano un uomo comune totalmente “urbanizzato” (interpretato da Rauno Kaibiainen) in un’avventurosa prova di sopravvivenza, dalla città alla foresta e ritorno. La sfida per lui sarà affrontare un’intera notte in mezzo a una natura selvaggia prima di riuscire a tornare alla civiltà, cercando di compiere azioni apparentemente elementari (accendere un fuoco o allontanare un animale) o di trovare un complice dialogo con le piante. Imprese in cui, forse, i ragazzi del pubblico sarebbero ben più abili dell’adulto che si trovano davanti. L’interpretazione mette in luce goffaggini e inadeguatezze, sconfinando a tratti nella macchietta. Se l’articolazione delle tematiche e l’apertura di domande proposte dalla drammaturgia rischiano di restare legate all’evidenza della pura vicenda, ad accompagnare gli spettatori verso nuove sollecitazioni è l’uso delle videoproiezioni: la suggestiva sovrapposizione di immagini a grande scala e movimenti scenici avrebbe potuto tuttavia indagare maggiormente le potenzialità di un’interazione, andando oltre la definizione di un’ambientazione. Tra scenari apocalittici e visioni oniriche, la domanda sul rapporto dell’uomo con la natura può trovare spazio per sconfinare in un immaginario da inventare e allargare il suo significato. (f.s.)
Rodolfo Sacchettini, Francesca Serrazzanetti, Carlotta Tringali


 Pur se molto distanti per linguaggio, Con me in Paradiso di Teatro Periferico e Fiabe Giapponesi di Societas/Chiara Guidi hanno invece saputo creare, tra scena e platea, le pareti elastiche di un parlamento politico. Non politico partitico, ma interessato a una politica della visione. Il primo porta sul palco del Ridotto un’originale operazione di innesto drammaturgico. Il testo di Mario Bianchi – che è innanzitutto uno dei “maestri” della critica e del racconto del teatro ragazzi – rielabora l’episodio neovangelico di Zaccheo in un confronto tra un italiano e un immigrato e viene poi attraversato in una scrittura scenica dal drammaturgo Dario Villa, che entra dentro al racconto per mostrare, in uno squarcio metateatrale, le reali problematiche di un laboratorio da lui condotto con un gruppo di migranti. Abdoulaye Ba, Mauro Diao e Siaka Konde riescono a non essere tanto la personificazione del migrante, piuttosto – grazie a una presenza disincantata e generosa – un esempio di procedimento critico tra contenuto e forma. Così l’impostazione didattica – certe volte sorprendentemente impietosa nei confronti dei soliti stereotipi sull’alterità – sguscia via dalla retorica e dà senso a un’abitazione dello spazio che non cerca la pulizia ma predilige la chiarezza, impreziosita a volte da tagli di luce e tableaux vivants.
Pur se molto distanti per linguaggio, Con me in Paradiso di Teatro Periferico e Fiabe Giapponesi di Societas/Chiara Guidi hanno invece saputo creare, tra scena e platea, le pareti elastiche di un parlamento politico. Non politico partitico, ma interessato a una politica della visione. Il primo porta sul palco del Ridotto un’originale operazione di innesto drammaturgico. Il testo di Mario Bianchi – che è innanzitutto uno dei “maestri” della critica e del racconto del teatro ragazzi – rielabora l’episodio neovangelico di Zaccheo in un confronto tra un italiano e un immigrato e viene poi attraversato in una scrittura scenica dal drammaturgo Dario Villa, che entra dentro al racconto per mostrare, in uno squarcio metateatrale, le reali problematiche di un laboratorio da lui condotto con un gruppo di migranti. Abdoulaye Ba, Mauro Diao e Siaka Konde riescono a non essere tanto la personificazione del migrante, piuttosto – grazie a una presenza disincantata e generosa – un esempio di procedimento critico tra contenuto e forma. Così l’impostazione didattica – certe volte sorprendentemente impietosa nei confronti dei soliti stereotipi sull’alterità – sguscia via dalla retorica e dà senso a un’abitazione dello spazio che non cerca la pulizia ma predilige la chiarezza, impreziosita a volte da tagli di luce e tableaux vivants. Un’apertura politica ambiziosa e sottile, invece, è ciò che può permettersi un’artista come Chiara Guidi, immersa da sempre in una ricerca che dal faro tecnico-poetico del mezzo teatrale fa luce sulla “puericultura”, sulla geografia epistemologica dell’infanzia e sulle sue complesse tassonomie. Le Fiabe Giapponesi sono un rituale che proprio nella relazione trova e rafforza il nervo della riflessione su questi segmenti di pubblico.
Un’apertura politica ambiziosa e sottile, invece, è ciò che può permettersi un’artista come Chiara Guidi, immersa da sempre in una ricerca che dal faro tecnico-poetico del mezzo teatrale fa luce sulla “puericultura”, sulla geografia epistemologica dell’infanzia e sulle sue complesse tassonomie. Le Fiabe Giapponesi sono un rituale che proprio nella relazione trova e rafforza il nervo della riflessione su questi segmenti di pubblico. La seconda parte del festival si è svolta all’insegna di uno dei materiali più antichi utilizzati dall’uomo: la carta. Si tratta di una produzione di Sacchi di Sabbia dal titolo Sshhhh! Pop_up teatrali e Corti di carta di Riccardo Reina, prodotto dal Teatro delle Briciole.
La seconda parte del festival si è svolta all’insegna di uno dei materiali più antichi utilizzati dall’uomo: la carta. Si tratta di una produzione di Sacchi di Sabbia dal titolo Sshhhh! Pop_up teatrali e Corti di carta di Riccardo Reina, prodotto dal Teatro delle Briciole. La carta che diventa ispirazione e disperazione, come tutte le cose che d’improvviso colpiscono a fondo e ci svelano un segreto. È il caso del primo dei tre Corti di Carta di Reina, in cui un uomo siede a una macchina da scrivere che, all’improvviso, come se entrassimo nella testa dello scrittore ispirato, comincia a produrre non più i classici suoni metallici dei tasti, ma note musicali. L’uomo, però, sembra non essere mai soddisfatto di ciò che scrive e si sbarazza, puntualmente, dei fogli che riempie, accartocciandoli e lanciandoli dietro di sé, fino a formare una montagna di carta che sembra assumere le sembianze di una Musa meravigliosa e terribile, perché misteriosa e inafferrabile, proprio come il fuoco della creatività.
La carta che diventa ispirazione e disperazione, come tutte le cose che d’improvviso colpiscono a fondo e ci svelano un segreto. È il caso del primo dei tre Corti di Carta di Reina, in cui un uomo siede a una macchina da scrivere che, all’improvviso, come se entrassimo nella testa dello scrittore ispirato, comincia a produrre non più i classici suoni metallici dei tasti, ma note musicali. L’uomo, però, sembra non essere mai soddisfatto di ciò che scrive e si sbarazza, puntualmente, dei fogli che riempie, accartocciandoli e lanciandoli dietro di sé, fino a formare una montagna di carta che sembra assumere le sembianze di una Musa meravigliosa e terribile, perché misteriosa e inafferrabile, proprio come il fuoco della creatività.
 Sulla semplicità si fonda anche Il re clown di Pietro Naglieri (Skèné), una favola quasi patafisica che sembra fare il verso all’Ubu Roi – a sua volta caricatura del dramma moderno – per consegnare ai bimbi dai 5 anni un messaggio chiaro sulla creatività, sul potere dell’arte, sulla condizione di emergenza degli artisti, sulle distorsioni del potere. Uno spettacolo che potrebbe stare in una piazza come in un salotto, perché ben piantato su codici scarni, leggibili e rispettosi della fantasia dello spettatore. La qualità sta anche qui, nel saper condensare in una struttura rigorosa le potenzialità del divertimento, l’interazione e dunque la collaborazione tra palco e platea nella costruzione di un immaginario che non senta il bisogno di storpiare accenti, ritrovando invece nella caricatura la scintilla della satira culturale per tutte le età.
Sulla semplicità si fonda anche Il re clown di Pietro Naglieri (Skèné), una favola quasi patafisica che sembra fare il verso all’Ubu Roi – a sua volta caricatura del dramma moderno – per consegnare ai bimbi dai 5 anni un messaggio chiaro sulla creatività, sul potere dell’arte, sulla condizione di emergenza degli artisti, sulle distorsioni del potere. Uno spettacolo che potrebbe stare in una piazza come in un salotto, perché ben piantato su codici scarni, leggibili e rispettosi della fantasia dello spettatore. La qualità sta anche qui, nel saper condensare in una struttura rigorosa le potenzialità del divertimento, l’interazione e dunque la collaborazione tra palco e platea nella costruzione di un immaginario che non senta il bisogno di storpiare accenti, ritrovando invece nella caricatura la scintilla della satira culturale per tutte le età.
 eroi» poggiando sulla scrittura di Gianni Rodari e sul corpo e la voce di Carla De Girolamo. La trama mitologica che fa da colonna è già per sé molto densa e ricca di riferimenti culturali, geografici e tematici. Se nelle prime sequenze il gesto pulito e la voce presente dell’attrice riescono a tenere insieme l’attenzione dello spettatore, è quando da un’avventura si entra nell’altra che il corpo – pur esperto nel gestire la centralità del palco – sembra non bastare più. Il linguaggio della narrazione finisce per plasmarsi troppo sulle cadenze dialettali utili a differenziare i personaggi, dimenticando come le proprietà trasformative degli oggetti e della figura e il disegno delle luci possano essere fondamentali nell’architettura del racconto teatrale. Pur se solide appaiono certe posture dello scheletro e certe inflessioni della voce, il ritmo si appiattisce in una storia troppo ancora ancorata al respiro della letteratura.
eroi» poggiando sulla scrittura di Gianni Rodari e sul corpo e la voce di Carla De Girolamo. La trama mitologica che fa da colonna è già per sé molto densa e ricca di riferimenti culturali, geografici e tematici. Se nelle prime sequenze il gesto pulito e la voce presente dell’attrice riescono a tenere insieme l’attenzione dello spettatore, è quando da un’avventura si entra nell’altra che il corpo – pur esperto nel gestire la centralità del palco – sembra non bastare più. Il linguaggio della narrazione finisce per plasmarsi troppo sulle cadenze dialettali utili a differenziare i personaggi, dimenticando come le proprietà trasformative degli oggetti e della figura e il disegno delle luci possano essere fondamentali nell’architettura del racconto teatrale. Pur se solide appaiono certe posture dello scheletro e certe inflessioni della voce, il ritmo si appiattisce in una storia troppo ancora ancorata al respiro della letteratura.