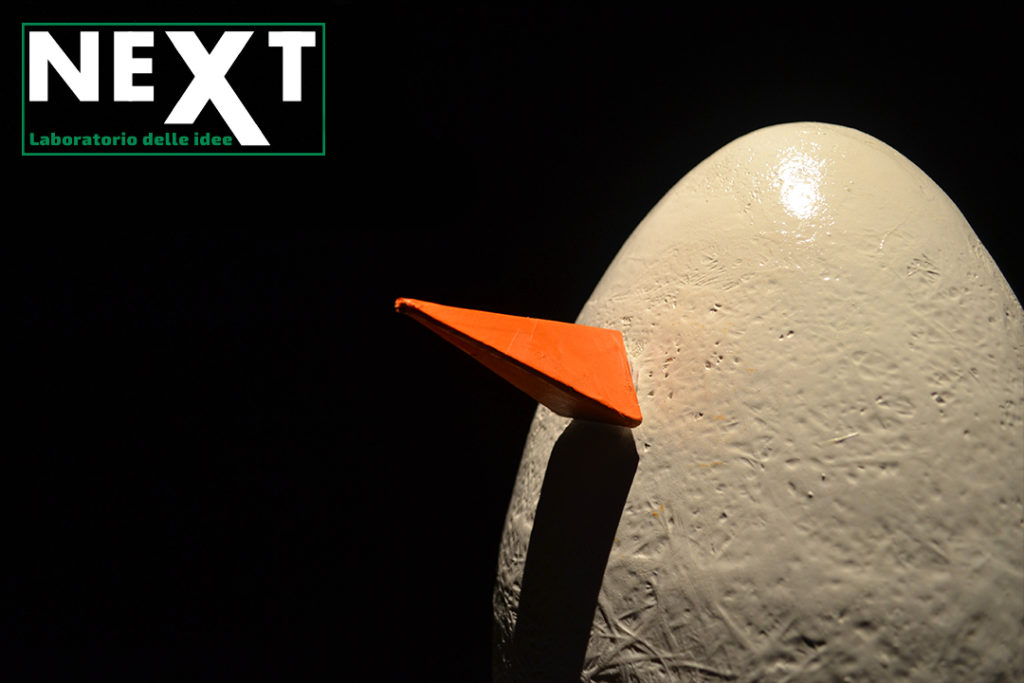“La parabola dell’animazione teatrale” di Piergiorgio Giacchè
Ripubblichiamo in questa sezione materiali, spunti, interviste già edite altrove in passato ma che ci paiono ancora utili per una discussione sulle forme del teatro che dialoga con diverse generazioni.
A seguire un saggio di Piergiorgio Giacchè, rivolto ai prodromi e ai movimenti dell’animazione teatrale, tratto da Il teatro salvato dai ragazzini. Esperienze di crescita attraverso l’arte (a cura di Debora Pietrobono e Rodolfo Sacchettini, Edizioni dell’asino, 2011). “La parabola dell’animazione teatrale” rientra fra gli interventi di artisti, studiosi, critici e operatori (fra gli altri: Maurizio Braucci, Vittorio Giacopini, Franco Lorenzoni, Giuliano Scabia, Virgilio Sieni, Emanuele Valenti) raccolti nel testo in seguito al convegno “Teatro e infanzia”, promosso da Goffredo Fofi e Marco Martinelli, e organizzato nel 2009 a Scampia da Punta Corsara. Un insieme di riflessioni teorico-pratiche e un’istantanea necessaria su alcune esperienze artistiche di rilievo, “con” e “per” i ragazzi, incentrate sul rapporto tra teatro e processi educativi.
0.
Chi non ha mai fatto l’animatore, scagli la prima pietra. Non c’è educatore, insegnante o perfino genitore che nel sociale, nella scuola o appena in famiglia non sia stato convertito o contaminato dall’animazione artistica e spettacolare. Sono decenni che l’animazione è diventata l’integratore dell’intrattenimento sociale e il redentore dell’educazione infantile e adolescenziale, per due motivi: uno vecchio come la scuola e riassumibile nel motto Delectando discitur e uno nuovo come la società dei consumi che, dopo aver moltiplicato i pani e i pesci, è passata dall’abbondanza alla creatività. L’animazione ha combinato e riassunto in sé il tempo della ricreazione e il modo della creazione, diventando la parola d’ordine e l’attività di disordine di tutto il processo educativo. Ancora oggi si valuta più l’inventiva che la competenza quando si parla di insegnanti; ancora oggi si crede più nella (immediata) liberazione che nella (faticata) libertà quando si parla di studenti. Ancora e soprattutto oggi ci sono animatori in ogni reparto del nostro immenso paese dei balocchi, sia pure ridotti a commessi del giocare per forza e del creare per finta. In particolare, l’animazione teatrale è sfuggita presto di mano ai suoi coraggiosi inventori e si è dichiarata – da tutti e per tutti – una facile scoperta.
1.
C’era una volta l’animazione teatrale, e da qualche parte magari c’è ancora. La sua breve storia teatrale è stata oscurata dalla sua geografia sociale. Oggi è un servizio esteso e invadente, ieri era un’esigenza artistica precisa e importante. La trasformazione – o il tradimento – a seconda dei punti di vista – è stata segnalata in tempo, ma la cultura di massa e la società democratica non hanno raccolto né l’allarme né tanto meno la scomunica [1]; anzi, non vedevano l’ora che l’arte si facesse da parte per poter disporre di un nuovo fattore e di un nuovo settore del proprio mercato, pardon “progetto”.
Invece la prima animazione aveva ambizioni e faceva rivoluzioni di una certa importanza, almeno per quelli che facevano o che fruivano teatro, e sarebbe bene ricordarne – sia pure in sintesi – il senso o forse i due sensi in cui si è spesa e da cui ha tratto qualche guadagno.
Io ero l’albero e tu il cavallo, si intitolava un libro di Franco Passatore. Io sono il cavallo, Marco Cavallo, rispondeva Giuliano Scabia [2].
La prima stagione dell’animazione teatrale ha esplorato da subito due vie: una si è coniugata con il gioco e si è immersa nell’isola dell’infanzia, l’altra si è combinata con il rito e si è mossa verso il continente degli adulti. Erano anni in cui la pedagogia e l’antropologia erano due dimensioni rinnovate o ritrovate, due discipline quasi coincidenti e nemmeno divise per classi d’età.
L’animazione teatrale – è bene ricordarlo e rivendicarlo – non è nata come un trucco per la sopravvivenza del teatro o come una trovata per piazzare spettacoli semplici e artisti deboli. È stata invece il prodotto esuberante e il processo di conquista di un teatro in grande stato di salute, che credeva di potersi sviluppare e di doversi proiettare negli atti e nei fatti della vita sociale.
C’è stato un momento in cui il teatro era diventato importante non solo per quei vertici di teoria e di regia che sono giustamente ricordati come i maestri, ma anche per la proliferazione e la generosità di quei “gruppi di base”, che insieme facevano “la somma degli attori”: attori intenti a riprodursi prima che a produrre, e attenti più al processo artistico che al prodotto spettacolare, più alla cultura teatrale da rifondare, da sviluppare, da diffondere che alla società del teatro così com’era ancora concepita e istituzionalizzata (e come è ancora adesso). Il teatro – quel teatro “terzo” che per un periodo non è stato secondo a nessuno [3] – si sentiva dunque così forte, nella sua povertà e nella sua differenza, da esplorare altri spazi e conquistare altri tempi. Intanto, gli spazi allora canonici e politici della scuola, fabbrica, quartiere, ma poi anche gli spazi dimenticati delle campagne e delle montagne e quelli vietati dei manicomi e delle prigioni… E quindi i tempi arretrati delle tradizioni o appena dei loro ricordi, ma poi anche i ritmi feriali di una quotidianità nevrotica ma insoddisfatta. E ancora e di più, i tempi negati delle condizioni più emarginate e sofferenti.
L’animazione teatrale non avrà fatto gran che, ma in quella prima stagione ha promosso il tempo festivo e lo spazio liberato dove e quando e per quanto gli è stato possibile. E – bisogna ricordare e sottolineare – sempre di arte del teatro si trattava, e non del suo uso strumentale o della sua funzione sociale [4]. L’essere strumento era semmai la sua premessa motivazionale, e guadagnare una funzione appena la sua ricaduta. Ma in mezzo e nel profondo c’era la cultura e l’arte teatrale con il suo senso (liberatorio) o il suo non senso (provocatorio): il suo linguaggio da alimentare e da sperimentare, e il suo coraggio di rischiare… Per una posta in gioco che era perfezionare il suo gioco e far proliferare il suo rito (in altri termini, la sua Finzione e la sua Relazione), e – quando si trattava di un buon teatro e di una buona animazione – l’obiettivo del gioco e del rito era la sua arte. Non la sua parte.
2.
Se si considera in tutta la sua ampiezza ed esuberanza, si può leggere quel momento o quel movimento di “animazione” – con la sua specializzazione pedagogica e attenzione antropologica – più che attraverso il segno che ha lasciato nel rapporto con l’infanzia e con la scuola (il “teatro ragazzi” nasce allora e poi magari cresce troppo), come il sogno di una ritrovata “infanzia del teatro”: infanzia segnata anche da una letterale perdita della parola a vantaggio del suono e del gesto [5], ma infine caratterizzata da una forte corrispondenza fra la illimitata esportazione del gioco del teatro e la sostanziale importazione di progetti e soggetti sociali a vantaggio dell’arte del teatro. Non si è trattato infatti solo di conquista di luoghi insoliti ma anche di modi finora estranei alla cultura teatrale, attraverso molte “spedizioni antropologiche” degli esploratori del teatro verso gli indigeni del sociale (i bambini in prima fila, ma non solo i bambini).
L’animazione ha avuto un doppio risultato: non solo quello relativo all’intervento teatrale proiettato all’esterno, ma anche quello di una altrettanto importante ri-animazione interna al teatro stesso. Nella gratuità e nella liminarità dell’animazione si sono potute scomporre e ricomporre le componenti dell’arte scenica, non solo con obiettivi funzionali ma anche con effetti rigeneratori. Ci si è aperti cioè a contaminazioni con le forme e le sfide di altre arti e linguaggi, situando il teatro al centro di una piattaforma performativa più ampia e più ricca. Il teatro e il suo attore – o “animatore” – si è esposto e proposto al centro delle varie forme espressive, in qualche modo “teatralizzandole”: dalla musica alle arti plastiche e visive, dalla poesia alla letteratura orale… Si può dire allora – per fare un esempio – che la rinascita e il successo degli attori-narratori è una delle eredità indirette dell’animazione; così come si può dire che, prima ancora dello sviluppo abnorme del teatro-ragazzi, l’animazione ha stimolato il recupero di stili oratori e oratoriali, di forme fiabesche e circensi, di oggetti e di corpi e di animali e di piante che da allora abitano ormai la scena – ogni scena – e la aprono a tutto quello che si può rapire e trasferire dal “teatro del mondo” al “mondo del teatro”.
Infine – anche per via e per merito dell’animazione – si è scoperto un pubblico più vasto, non solo come quantità ma come qualità e provenienza; un pubblico contattato e quindi catturato più attraverso il fare che il vedere teatro, un pubblico spesso battezzato da primitive esperienze sceniche e quindi cresimato come complice, e come ospite, e infine come parente. In effetti – come si sa – negli anni e per via degli atti della prima animazione, il “fare teatro” è diventato più diffuso e più importante del “vedere teatro”, e questo cambiamento ha allevato molti attori e rieducato molti spettatori. Anche se ha finito poi per eccitare fin troppi “assessori”, che – come si sa – non sono stati estranei al suo eccessivo sfruttamento e definitivo mutamento…
3.
Se si guarda – per una volta – al pulviscolo delle presenze attive e delle iniziative diffuse che costituiscono la nebulosa del teatro e – soltanto dopo – si considerano le stelle di prima grandezza artistica, ci si può accorgere di come il “teatro antropologico e pedagogico” di trent’anni fa, sia rapidamente passato da fermento artistico a fenomeno sociologico per non dire politico, con conseguenze imponenti sia per la vita sociale che per la sopravvivenza teatrale.
In sintesi bruciante e in modo approssimato si può riassumere questo capitolo della sua “capitolazione” – se così si può chiamare il passaggio dal senso alla funzione. Il teatro di base e quindi di ricerca e infine di sperimentazione è un fenomeno troppo vasto e vario per essere contenuto in una sola parabola. E però si può disegnare una linea generale, che magari non spiega quasi nulla ma che riguarda quasi tutti i gruppi teatrali nati negli anni settanta e ottanta e vivi ancora oggi: le “isole galleggianti” (per usare la metafora e la ricetta di Eugenio Barba) che avevano attivato il loro commercio teatrale con la terra ferma del sociale [6], usando le regole primitive dello scambio reciproco ovvero del dono (donare animazione al sociale per ottenere spazi e fondi utili alla sperimentazione teatrale), si sono trasformate – prima – in penisole di un’attività festiva e di consumo saldamente ancorata all’istituzionalizzazione dell’effimero (leggi: assessorati alla cultura). Ed hanno finito – poi – per sistemarsi fra i settori di un’attività feriale e di servizio che ancora oggi assicurano la sacrosanta sopravvivenza a centinaia di attori che di giorno fanno gli operatori e di notte gli artisti, dividendosi a metà fra la parte e l’arte. Così, fra la funzione da vendere e il senso da acquistare è nato un difficile equilibrio; e fra gli atti di vita artistica e i fatti della sopravvivenza degli artisti è sorta una certa contraddizione.
Niente di male, anzi un po’ di squilibrio e di contraddizione non guasta affatto il teatro: lo mette in condizioni di toccare terra e darsi una ragione, ma al contempo lo può spingere verso l’urgenza di sragionare in modo diverso e di poter guardare al cielo. Niente di male, soprattutto per tutti quelli che man mano perdevano la voglia o non avevano il talento per dare scalate o occhiate al cielo: comunque sia, il diffuso e confuso “teatro servizio” non è un “peccato”, ma anzi introduce una selezione benefica e una stratificazione necessaria, che mantiene un humus fertile indispensabile all’ecologia del teatro e all’agricoltura della sua arte…
E il teatro e l’arte – come si sa – si sviluppano meglio in un terreno abitato e lavorato: ognuno in effetti può vedere (e dovrebbe aver già visto) che è nelle zone geografiche e nei momenti storici di maggior densità teatrale che nascono proposte spettacolari e ricerche estetiche più alte (sia da parte degli attori che da parte degli spettatori, anzi di sempre nuovi attori e nuovi spettatori).
Tutto sta ad essere consapevoli della situazione, tutto sta a saper sfruttare lo squilibrio e saper scegliere dentro la contraddizione, a vantaggio del senso (teatrale) e non della funzione (sociale).
E allora quasi tutto sta su chi tiene il problema politico per il manico, altrimenti il tema poetico può avere un brutto svolgimento.
4.
Restando al teatro (ma davvero si potrebbe allargare il campo e lo sguardo a tutte le attività culturali) i personaggi e gli interpreti del dramma di una “politica culturale”, da allora in continua espansione e in altrettanto continuo svuotamento, sono due: l’attore e l’assessore. Direi anzi che l’attore è stato quasi sempre l’affannoso interprete di un personaggio politico e amministrativo fin troppo dominante. Ormai, il “regista” degli eventi, il costruttore dei “contenitori”, il promotore e il direttore delle arti e degli spettacoli è il Politico di turno, peraltro sempre meno attento al sociale e sempre più intento all’elettorale. Ma, perversioni a parte, il fatto è che il rapporto tra assessore e attore è stato fin da subito male impostato, e non poteva che portare a una forma di pesante subalternità, in definitiva suicida per la cultura e in fondo anche per la politica.
Fra attore e assessore (come fra animatore e preside, tra operatore e organizzatore…) non si dovrebbe mai porre una questione di potere ma di sapere. Sul piano del potere l’artista non ha voce e la contesa non ha storia. Su quello del sapere invece, le competenze si dividono e i ruoli possono anche stratificarsi in modo “rivoluzionario”, dando al Cesare di turno soltanto quello che gli compete e all’Io di chi propone e si espone una quota non indifferente di autorità (e di responsabilità). In breve, il saper fare dell’artista deve mantenere la sua autonomia e rivendicare una sua preminenza, altrimenti lo squilibrio e la contraddizione non sono più agibili né visibili. E l’enigma complesso del teatro – della sua organicità e gratuità e relazionalità – finisce per degenerare in un equivoco.
Quale equivoco? Quello di un teatro “applicato” e spesso “smembrato” (in dizioni e lezioni, traduzioni e drammatizzazioni, addestramenti e abbellimenti, volta a volta orientati a soddisfare i più diversi clienti e obiettivi), che può giustamente essere meglio amministrato da un assessore che non da un attore, meglio da un preside che da un animatore…, più consapevoli e veri responsabili del servizio culturale e sociale a cui molti teatri si iscrivono e al quale tutto il teatro finge di (e finisce per) sottomettersi. In effetti, rivendicare una funzione e contribuire a un servizio è di vitale importanza per i teatranti (se non per il teatro), e tuttavia non è mai artisticamente conveniente (ma solo politicamente convincente) ridurre l’autonomia della cultura teatrale o nascondere (e nascondersi) la questione prioritaria del senso o del non-senso del teatro.
E però così è andata, se si guarda al seguito della annosa parabola dell’animazione: sempre più in crescita quantitativa come servizio (soprattutto scolastico), e in calo qualitativo come sfida (soprattutto sociale). Anche il più agguerrito “teatro sociale” (recentemente ribattezzato) non riesce più a rovesciare la frittata del potere dalla parte del sapere. Si spende in sacrosante manovre difensive, ma continua a scontare lo scarto fra la sua esplicita e inevitabile integrazione, e l’implicito e spesso inconfessato valore della sua provocazione [7].
Forse era tutta qui la forza dell’animazione negli anni della sua prima e bella stagione: lo stato di salute del teatro lo si misura anche e soprattutto sulla sua capacità di inserirsi nel sociale come contraddizione, e perfino come contrapposizione.
5.
Intanto però, a tutt’oggi – limitando l’osservazione al rapporto tra teatro e scuola – si può dire che il consolidamento dell’animazione procede, ma in modo inversamente proporzionale alla sua incisività. In ogni scuola di ogni ordine e grado gli animatori teatrali sono più numerosi e forse meno precari dei supplenti. Anche se si giocano ogni anno il loro “contratto” nel saggio di fine d’anno obbligatorio e consolatorio: uno spettacolo superaffollato sia in scena che in platea cui è affidato il compito di realizzare quella quadratura del cerchio fra diritto al gioco e dovere dello studio di antica tradizione.
Sono ancora frequenti nei palcoscenici scolastici le tragedie greche o le commedie in inglese, ma sempre più spesso si tratta di libere composizioni o ardite interpretazioni di temi – più che di testi – che una faticosa drammaturgia-coreografia deve mettere in bella, perché sia insieme la mostra e la festa della scuola. Ma non sono questi i tempi di gloriose tradizioni ma di stantie abitudini, e il teatro della scuola più insiste e meno resiste alla concorrenza, più si consolida e meno risponde all’esigenza della novità; si vuol dire che sta invecchiando come proposta espressiva verso gli studenti, e che sta scadendo come portatore dell’immagine di una scuola sempre all’arrembaggio dell’aggiornamento. Le sue qualità funzionali di ausilio didattico e di effetto terapeutico e di corroborante della sociabilità sono ancora indiscusse e però sono già “scadute”, come avviene per un vecchio prodotto, un vecchio consumo [8].
Così inevitabilmente e inesorabilmente, la diversità e la disobbedienza, la libertà e la provocazione del teatro fatto dai ragazzi non è più un valore, e nemmeno un colore. Parlo della sua “immagine” nel mercato del servizio, e non della sua effettiva sostanza ed efficacia. Parlo di come se ne parla (o non se ne parla più), guardando al fenomeno del teatro a scuola su vasta scala, del suo generale impianto sociologico e del suo generico impatto culturale. In questo giudizio o in questo destino non sono e non si sentiranno coinvolte le esperienze di punta (corsara e non), o le realtà artistiche più alte e più solide. Ma chi crede di sentirsi lontano e diverso da ciò che succede nell’humus, ovvero nello strato ecologico più basso del pianeta teatrale, sbaglia. E sbaglia due volte.
Primo, perché la valutazione del teatro nell’attuale cultura politica e politica culturale è influenzata più dalle iniziative diffuse e confuse che non dalle poche esperienze di riconosciuto valore o di accertato successo. Secondo, perchè non è affatto vero che, nelle infinite realtà minori dell’animazione scolastica, manchino idee ed energie significative; e non è vero che i loro esperimenti spettacolari ed elaborazioni culturali siano di nessun conto o di nessun effetto. Molti animatori e attori continuano a lavorare nelle scuole con la massima serietà e con la massima fantasia, senza disattendere al compito di contribuire – anch’essi – alla ricerca di senso dell’arte scenica, sia pure dimensionato e orientato verso gli attori “in erba” e gli spettatori “per caso” del teatro scolastico.
E fra gli attori e gli spettatori di questo vivaio, alcuni si staranno già mettendo alla ricerca del teatro di domani; e prima o poi anche loro cominceranno a fare i conti con la funzione da vendere, magari nascondendosi il tema del senso da acquistare…
Ma non è detto che sia inevitabile. E dunque non va detto.
6.
Vada come vada, è comunque sul senso del teatro che si dovrebbe tornare a fare movimento e opinione. A fare cioè resistenza e disobbedienza, per rimettere al centro dell’attenzione la contraddizione o almeno la competizione fra il “sapere” e il “potere”. Ma chi può davvero permettersi di riequilibrare il rapporto tra senso e funzione del teatro, tra sapere e potere, tra fare e vendere arte e cultura?
Prima di tutto gli spettatori-critici. È inutile che ci nascondiamo le responsabilità di quei pochi spettatori che si occupano e si preoccupano del teatro, che hanno domande aperte e un rispetto fiducioso verso gli artisti. Sono (o siamo) pochi, e circondati da un pubblico e da un politico che non si deve mediare ma contrastare. E l’assessore – almeno qui da noi – è infine la figura che suo malgrado incarna di buon grado il “politico pubblico” e il “pubblico politico”. Bisogna smettere di credersi intercessori delle grazie politiche e dei fondi pubblici, scribacchiando lodi e segnalando premi qua e là. Sia verso il pubblico che verso il politico (a cominciare dall’assessore ma a finire con l’abbonato), è un altro l’atteggiamento critico efficace e non più rinviabile: “Colpirli tutti per educarne anche solo uno”, è il compito attuale del critico, che deve finirla di ritenersi un recensore ormai senza lettori e senza valori.
Il teatro è aperto a tutti ma non è di tutti: non tutti partecipano alla sua relazione ma appena al suo consumo. Lo “spettatore teatrale” deve essere invece partecipante e infine parente – anche terribile – di chi il teatro lo fa: non è l’arbitro del gusto o il giudice del successo ma la controparte di un’arte dalla quale deve trarre profitto, interesse, guadagno culturale. Per questo ha il diritto dovere di fischiare o di applaudire, ma per davvero: per esempio applaudire non come si fa ai funerali, ma come non si fa mai alle nascite!
Poi, ma certamente più importanti degli spettatori e dei critici, devono e possono fare resistenza e disobbedienza gli attori e i registi della ricerca del teatro (più che del teatro di ricerca), i quali non sono le “avanguardie artistiche” ma quelle davvero “politiche” del mondo teatrale.
Non fraintendiamo. la politica del teatro è una poetica, anzi molte poetiche purché consolidate ed efficaci: consolidate nella loro inquieta direzione di ricerca ed efficaci per quanta inquieta riflessione riescono a stimolare negli spettatori. Si potrebbe dire gli artisti “bravi”, ma è meglio dire “buoni” e, se e quando ci riescono, “belli”. Si dovrebbe però precisare – per evitare l’equivoco di un giudizio di valore – “quegli artisti che sanno di avere o di essere un teatro affermato”, nel senso di riconosciuto dagli altri e per se stesso. O meglio: quelli che si trovano – per avventura e per scelta – in una posizione di forza provvisoria ma di libertà stabile. Teatranti liberi stabili: non tutti gli artisti della scena sono liberi di stabilizzare la propria domanda di senso – e forse questa della libertà è una definizione di genere migliore di sperimentazione, innovazione, ricerca, avanguardia, eccetera…
7.
Ma cos’è questo misterioso senso del teatro? È appunto il suo mistero.
Il senso del teatro non sta tanto nel suo trucco (artigianale) o nel suo segreto (sapienziale), ma nell’esigenza e nella possibilità – che non è di tutti i teatri – di sfiorare e sfidare il suo mistero: qualcosa di semplice a dispetto della parola, poiché è insieme ovvio e misterioso il suo stesso desiderio o bisogno di rappresentare altro e di incontrare l’altro. A partire dal più banale e immediato ‘altro’ – quello del personaggio da interpretare e quello dello spettatore da coinvolgere – fino al più difficile e confuso ‘altro’ che è infine la dimensione avvolgente e incombente della sacralità.
In parole povere e davvero laiche, anche per il teatro e nel teatro vale quella relazione con il sacro che è da sempre la miniera che attrae le sonde conoscitive e le danze performative dell’arte (come anche della religione, della magia, della follia…). Quell’alterità intima e insieme quell’alterità verticale (alta o profonda, tragica o comica… è lo stesso) verso la quale il teatro muove le sue finzioni e fabbrica le sue illusioni, inseguendo ma insieme irridendo il suo mistero. Nella libertà e nell’obbligo di consistere nella parodia del Senso maiuscolo, sta la differenza e la disobbedienza del senso minuscolo del teatro.
Infine tutto il teatro è minuscolo, anzi è un nonnulla, in tutti e due i contro-sensi (nulla e non nulla) e nel loro non-senso. Il teatro non è e non costruisce mondi alternativi. Il teatro non è un mondo alla rovescia ma appena un modo alla rovescia. Anzi un continuo arrovesciamento: un arrevuotamento, per dirlo con i ragazzi di Scampia…
Il suo modo è speculare e quindi mai coincidente con la realtà oggettiva verso e contro la quale si espone. Le sue regole e sapienze e tendenze (trucchi, segreti e misteri) non hanno nulla di alternativo ma viaggiano dentro una convenzionale e a volte convincente alterità. Piccole deviazioni e non devianze, ma in grado di trasmettere leggere mutazioni e ansie di divenire nello spazio tempo sospeso e festivo di poche ore di incontro-scontro con un pubblico.
Il suo miracolo, quando si avvera sia pure per pochi istanti, induce un’azione riflessiva vitale in chi lo fa e chi lo guarda. Niente di più, ma niente di meno, quando è efficace.
La battaglia per la sua efficacia di senso è improba, non vince quasi mai e convince ancora meno. Ma il teatro ha appena questo senso. E il teatro funziona solo quando questo senso si fa apprendere e detta le regole e le possibilità del fare.
Ci vorrebbero un attore estetico e uno spettatore critico. Ma forse addirittura il contrario: ci vorrebbe – come diceva Carmelo Bene – un attore critico e uno spettatore estetico… E qualche volta si ha la sensazione – in scena e in platea – che qualcuno ci possa riuscire davvero.
8.
Chi ci riesce? Restando nei limiti dell’animazione scolastica e nel quadro del rapporto tra “teatro e infanzia”, ci riesce chi fa teatro per ragazzi o chi fa fare il teatro dei ragazzi? Forse nessuno dei due.
Ci riesce quel teatro che difende la sua acqua sporca con dentro il bambino o il ragazzo che avrà definitivamente rapito. Chi cioè fa teatro “con” bambini e “con” ragazzi, nel senso di un complemento più di materia che di compagnia. Gli esperimenti di teatro infantile e le esperienze di teatro adolescente rispettivamente dei Raffaello di Cesena e delle Albe di Ravenna non saranno modelli ma sono precisi esempi “storici” di questo complemento in ablativo semplice (come lo è – nel suo ambito – il teatro della Fortezza di Volterra che ha finto di chiudersi in carcere per catturare prigionieri).
Ci riescono quegli attori e animatori che non si rifiutano di fare dell’animazione un servizio, ma sono attenti a tradurlo e tradirlo nella ricerca del senso del proprio teatro. Ci può riuscire in definitiva chi mette sempre il teatro al primo e al secondo posto, e quando se lo può permettere anche al terzo posto, spiazzando le logiche del potere con le sfide del sapere e – per buttarla in politica – sottomettendo l’assessore all’attore, se non altro in virtù di un’etimologia che vede l’assessore (adsideo) seduto sulla cultura e l’attore in piedi, nell’atto di viverla e respirarla come l’aria.
“La cultura è l’aria e non un’area” – diceva ancora Carmelo Bene tanti anni fa [9], prima della primitiva animazione e della sua successiva irresistibile ascesa e poi discesa in tutto l’orario e il calendario della politica culturale. Prima dell’espansione del teatro-consumo e della sua promozione in teatro-servizio. Prima delle stagioni eccezionali dell’effimero e del successivo paradossale postulato della sua permanenza. Eccetera, eccetera.
In quest’aria – è bene ricordarlo – vivono e dovrebbero crescere tutti gli attori sociali e non solo quelli teatrali. Anche gli attori sociali più piccoli, che anzi devono imparare a respirarla e a farla propria. La funzione pedagogica del teatro è tutta qui, nella sua vocazione a fungere da anticamera del senso.
Il teatro e l’infanzia hanno una storia vecchia come il cucco. Il teatrino fino a qualche decennio fa faceva parte dei giocattoli, anzi tutti o molti giocattoli funzionavano come un teatrino. Forse però “il teatro del gioco” non è troppo cambiato, anche se non lo si scopre più baloccandosi con bambole e soldatini e tappini di birra ovvero “animando” tutte le cose che capitavano nella scena di quell’attore (appena) nato. È il passaggio tra il teatro del gioco e il gioco del teatro – quello più adulto e consapevole – che sta diventando problematico; certo per via dell’arcaicità che sconta il linguaggio teatrale rispetto ad altri mezzi più magici o soltanto più potenti. Ma anche per via della pesantezza ideologica e della responsabilità didattica che (nella scuola ma anche in famiglia) ha inquadrato di fatto l’animazione teatrale tra le materie d’istruzione, anziché lasciarla agire di diritto come letterale “ricreazione”.
9.
E che rapporto c’è poi tra l’infanzia e il teatro d’arte, quello dei grandi e quello vero dove si portano spesso anche le scuole, una volta finito il gioco del teatro a scuola?
I bambini hanno un diritto di cittadinanza naturale nel teatro, anche se non si sa bene dove metterli, se in scena o in platea, visto che in loro la scissione dei ruoli non è chiara o non è ancora nata.
Eugène Ionesco, intervistato su quando aveva cominciato a far parte del teatro ha risposto “da quando avevo 9 anni”, ricordando la sua “prima volta” a Parigi quando lo avevano portato ai giardini del Luxembourg a vedere i Guignols.
Quando dunque si comincia a far parte del teatro? Da quando il bambino apprende o si sorprende a incantarsi davanti a una grande scatola di “gioco da vedere”, che sospende ma poi alimenta il suo instancabile “gioco da fare”. Quando dunque il teatro del gioco non basta o non soddisfa, andrebbe ricaricato e aiutato dagli interventi adulti di “gioco del teatro”. Ma allora – anche prima di scomodare i veri attori – ci vorrebbe qualcuno che si infili dentro un teatrino o dietro le pagine di un libro; basterebbe un gesto che si accende come una luce oppure una voce che si nasconde nel buio, per svegliare o per addormentare… In realtà, per “assognare”, ovvero per accompagnare il bambino (attore e spettatore insieme) non dentro il mondo dei sogni ma dentro il sogno di un gioco capace di trionfare sulla realtà.
Ma oggi non ci sono più né zie né lettori [10]: non ci sono più né babbi né burattini. I genitori e gli animatori non si divertono a costruire pinocchi e non giocano più approfittandosi dei bambini. Si gioca per i bambini ma non con i bambini, nella migliore delle ipotesi. O più spesso si resta spettatori dei giochi dei bambini, come quelle platee di amici e parenti che – agli spettacoli di fine d’anno scolastico – incoraggiano e festeggiano l’azione espressiva dei bambini, senza accorgersi di svalorizzare e mortificare l’azione riflessiva. Applaudono ogni loro esibizione, ma intanto hanno paura che si perdano nell’incantazione: vogliono dei bambini disincantati e insieme incantevoli, come richiede la società o il mercato dello spettacolo. Riducono il gioco del teatro alla mostra di sé, mentre il teatro del gioco si confonde e affonda nella quotidianità di un’infanzia senza fine e senza un fine.
Sono persino in troppi ad amare e animare l’infanzia, tra genitori e insegnanti e infermieri clown e giocolieri prezzolati nelle feste di compleanno, ma nessuno le fornisce più i miti e i riti, i personaggi e gli interpreti, i modi e i mezzi che con cui a loro volta possono animare il mondo o scoprire il mondo dell’anima. Invece – a dispetto di quel che credono i grandi – la piccola scatola del gioco teatrale potrebbe essere ancora l’unica o l’ultima in grado di contrapporre l’incanto all’anestesia, la riflessione all’esibizione, l’ambizione del divenire altro alla pigrizia dell’essere come si è.
È un gioco adulto il teatro d’arte, anche quando è fatto con i bambini: è un gioco difficile da maestri e un po’ da orchi, che si fa per continuare a crescere e a trasformarsi, mangiando i bambini… insieme ai bambini.
E infine, per quanto riguarda il suo apprendimento o la sua condivisione, la più grande difficoltà sta nel liberare la sua facilità. Il teatro non va insegnato ma fatto funzionare, e il gioco è fatto. Il suo rapporto con il gioco e con il rito e con la festa è già dentro la scatola, sia pure nei piani più alti o più profondi della sua confezione.
Il teatro-bambino della Socìetas Raffaello Sanzio e il teatro-ragazzo del Teatro delle Albe, per esempio, lo hanno capito e lo hanno fatto. Lo hanno scoperto e lo hanno inventato. Puntando in alto e non guardando in basso, sfidando e non consolando i loro giovani abitanti, li hanno catturati e in qualche modo se li sono mangiati – spettatori o attori che fossero.
Sinite parvulos venire ad me – diceva un grande maestro di teatro sacro. Ma non viceversa.
(Piergiorgio Giacchè, “La parabola dell’animazione teatrale”, in Il teatro salvato da i ragazzini, a cura di Debora Pietrobono e Rodolfo Sacchettini, Edizioni dell’asino, Roma 2011; pp. 46-65)
[1] Nel 1980 «Scena», la rivista più significativa del “movimento teatrale” di quegli anni (fin troppo dimenticata, ma all’epoca più importante di «Sipario»), decideva di togliere la parola “animazione” dal sottotitolo della sua testata e di pubblicare un manifesto che ne decretava pubblicamente la “morte”. Remo Rostagno, primo firmatario assieme a Marco Baliani e Maya Cornacchia, ha recentemente ricordato questo fatto in un’intervista pubblicata in: Catarsi. Teatri della diversità, nn. 49-50, giugno 2009, (Crf. P. IV della sez. Documenti).
[2] Io ero l’albero (tu il cavallo) è il titolo di un famoso libro sull’animazione curato da Franco Passatore (Guaraldi, Rimini-Firenze, 1972) mentre l’azione di Marco Cavallo ha riempito e qualificato il lavoro condotto da Giuliano Scabia all’ospedale psichiatrico di Trieste durante la “rivoluzione” di Basaglia.
[3] “Terzo teatro” è stata una corretta definizione data da Eugenio Barba al vasto fenomeno del teatro di gruppo degli anni Settanta e Ottanta: autodidatta ma professionista, nato e cresciuto fuori dalle scuole ufficiali e dal “primo” teatro istituzionale, ma anche diviso e diverso dalle avanguardie che avevano da tempo costituito una “seconda” possibilità.
[4] Sulla questione del rapporto tra la funzione sociale e il senso teatrale, maggiori dati e più approfonditi commenti si trovano in: P. Giacchè, Il Teatro come ‘attore’ del terzo sistema, in: “In Compagnia. Materiali per la costruzione di un quadro di riferimento per lo sviluppo dell’occupazione degli operatori artistici teatrali: il teatro quale strumento di crescita sociale”, (relazione di ricerca), Emilia Romagna Teatro, Stampa Tem, Modena, 1999, pp. 40 – 64.
[5] Ci si vuole riferire non tanto alla svalorizzazione della letteratura drammatica (che non è più sinonimo di teatro), quanto alla valorizzazione dei linguaggi non verbali, alla ritrovata preminenza del corpo dell’attore sulla mente dello spettatore – fenomeni che hanno caratterizzato sia le poetiche che le politiche del “nuovo” teatro, a partire dalle avanguardie degli anni ’60 e ad arrivare alle dimensioni o aspirazione di un “teatro antropologico” e del suo mercato transnazionale.
[6] Le isole galleggianti sono una celebre e perfino abusata metafora coniata da Barba e dall’Odin Teatret, che ha funzionato per anni da “ricetta” politica e poetica per moltissimi gruppi di teatro anche di orientamento ideologico e stilistico diverso: c’è stato un lungo periodo in cui ha funzionato lo “scambio” fra un’attività animatoriale da offrire a enti pubblici e privati, e la concessione di spazi e tempi, fondi e riconoscimenti, da investire sulla produzione spettacolare e sulla ricerca artistica.
[7] “Teatro sociale” è una recente e ampia autodefinizione del mondo del teatro impegnato e applicato in vari ambiti sociali; un convegno a Milano di qualche anno fa, con la presenza e sotto l’egida di Richard Schechner, ha cercato di raccogliere quest’area e di rilanciarne le proposte; non si vuole dare uno sbrigativo giudizio da scettici, ma soltanto sottolineare l’importanza di un nodo irrisolto – fra integrazione e rivoluzione – quando si ha a che fare con i due modi e momenti non sempre sovrapponibili dell’intervento sociale e dell’esperienza artistica.
[8] Cfr. P. Giacchè, Le bugie della scuola e quelle del teatro, «Art’O», n. 4, gennaio 2000, pp. 42-45.
[9] Le citazioni rubate a Carmelo Bene si trovano in: Carmelo Bene, La voce di Narciso (a cura di Sergio Colomba), Il Saggiatore, Milano, 1982.
[10] Al mondo ci sono più zie che lettori è il titolo di un piccolo prezioso saggio di Peter Bichsel (Marcos y Marcos, Milano, 1989), pieno di suggestioni e saggezze utili a chi riflette sul tema della cultura e sul mondo dell’infanzia.
 In questa favola lirica, incorniciata dai colori sgargianti delle animazioni (fluide e ben curate da Daniele Salaris), i tragitti a piedi diventano grotteschi videogame da abitare con gesti meccanici, il lungo tragitto per lasciare la Siria e raggiungere la Svezia attraversa capitali/cartolina, ma c’è spazio anche per la schiacciante pressione dei media, quando il profugo deve rispondere a mille domande sotto il peso dei microfoni o imparare un arzigogolato e poliglotta decalogo di regole da rispettare.
In questa favola lirica, incorniciata dai colori sgargianti delle animazioni (fluide e ben curate da Daniele Salaris), i tragitti a piedi diventano grotteschi videogame da abitare con gesti meccanici, il lungo tragitto per lasciare la Siria e raggiungere la Svezia attraversa capitali/cartolina, ma c’è spazio anche per la schiacciante pressione dei media, quando il profugo deve rispondere a mille domande sotto il peso dei microfoni o imparare un arzigogolato e poliglotta decalogo di regole da rispettare.